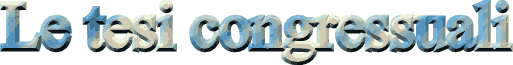
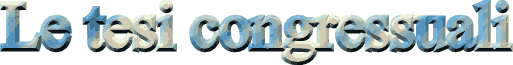

1. Con l'accordo del luglio 93 si è fissato un modello contrattuale
omogeneo per tutti i settori.
L'impianto sostanziale di quel modello è ancora valido e va ora collegato alle nuove
condizioni che sono state create dalla drastica riduzione del tasso d'inflazione .
Alla luce dell'esperienza dei primi 4 anni di applicazione del modello si possono tuttavia
mettere sotto osservazione alcuni elementi di criticità.
2. Nei settori privati la contrattazione
integrativa riguarda una minoranza delle aziende, determinando con ciò una disparità di
trattamento tra lavoratori della stessa categoria che guadagnano di più o di meno a
seconda della dimensione della propria azienda.
Nei settori pubblici la contrattazione di secondo livello e ancora allo stato iniziale,
sia perché in moltissime amministrazioni non c'è autonomia di bilancio, sia perché non
sono mai stati definiti parametri di riferimento per misurare la produttività.
C'è inoltre un problema reale che deve essere valutato attentamente: con l'attuale
modello contrattuale, in qualunque momento venga collocata la contrattazione integrativa,
si crea una situazione per cui nell'arco di due anni sono previsti tre contratti. Uno
nazionale all'inizio del quadriennio; uno integrativo nel mezzo; uno nazionale alla fine
del biennio solo economico correlato agli scostamenti dell'inflazione.
3. La contrattazione triennale con un contratto integrativo a metà tempo, appare più razionale sia per le imprese che per il lavoro.
4. Va respinta la teoria della tendenziale
incompatibilità tra l'inflazione-zero e l'esercizio dell'azione contrattuale.
L'inflazione bassa, o una inflazione zero, costituiscono un grande vantaggio su tutti i
fronti: per la protezione del reddito delle famiglie; per la competitività delle aziende;
per il costo del debito pubblico.
In questo senso deve essere ribadito il pieno valore del contratto nazionale come
strumento concreto di unificazione della condizione dei lavoratori e di uguaglianza dei
loro diritti.
Si tratta semmai di precisare con maggiore attenzione la funzione regolatrice rispetto
alle materie ed al rapporto con i contenuti salariali della contrattazione di secondo
livello.
5. Il principio fondamentale su cui deve poggiare l'impianto è che la materia contrattuale è di stretta pertinenza del sindacato non solo per il CCNL ma anche per la contrattazione integrativa. Le RSU dell'azienda concorrono alla elaborazione, e soprattutto ne gestiscono i risultati: in questo campo esercitano tutta la loro potenzialità di verifica e contenuto di attuazione.
6. Per il pubblico Impiego deve essere ben definita l'area di attuazione della contrattazione integrativa, precisando gli ambiti e l'autonomia delle controparti sugli aspetti retributivi, sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, ecc.;
7. Per i settori privati, è necessario che
nei fatti il secondo livello contrattuale possa venire esercitato anche nelle piccole e
piccolissime aziende.
Questo sarà possibile soltanto se oltre alla contrattazione aziendale ci sarà la
contrattazione territoriale per categorie produttive.
8. Nel progetto di contrattazione integrativa
territoriale non esistono certezze di efficace attuazione attraverso gli strumenti
tradizionali a disposizione del sindacato. E la stessa lotta contrattuale non è una
garanzia di attuazione generalizzata dei suoi esiti per tutti i lavoratori della categoria
interessata.
La contrattazione di secondo livello territoriale deve quindi prevedere la possibilità di
realizzarsi mediante strutture bilaterali tra rappresentanti di impresa e sindacato. Una
struttura bilaterale che interviene a sostegno del reddito del lavoratore di cui il
salario è solo una componente. Per gli uffici di piccole dimensioni si può pensare ad
una contrattazione territoriale anche nei settori pubblici, in particolare per
l'organizzazione del lavoro.
9. I livelli contrattuali debbono restare due. Uno nazionale, normativo e salariale, avente come scopo la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni la cui dinamica - pur se coerente con i tassi di inflazione programmata - tiene conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. Ci dovrà essere inoltre la contrattazione di secondo livello, che può essere aziendale o territoriale.
10. Attraverso Strumenti Bilaterali si possono
realizzare nuove forme di partecipazione dei lavoratori oggi esclusi da qualsiasi
beneficio fatta eccezione per le garanzie del CCNL.
Attraverso una aggregazione degli interessi a livello territoriale, l'accordo bilaterale
potrà prevedere forme di mutualità categoriale aumentando le protezioni sociali.
11. Per le aziende in cui non è realizzabile la contrattazione integrativa, la UIL proporrà alle altre confederazioni ed alle associazioni di imprese questo livello negoziale provinciale puntando alla creazione di accordi bilaterali per il sostegno al reddito ed alle protezioni sociali, anche attraverso erogazione di servizi.
La politica degli orari
12. Nell'azione contrattuale un capitolo
particolare è costituito dalla politica degli orari.
Nei momenti di stagnazione o di modesto sviluppo economico, la riduzione degli orari non
è l'obiettivo primario dei lavoratori e crea problemi aggiuntivi alle capacità
competitive delle imprese esportatrici.
In questa fase le priorità degli interessi dei lavoratori sono quelle del lavoro e del
salario.
13. E tuttavia una politica degli orari per
una loro graduale riduzione si rende necessaria.
Occorre però evitare che ad una riduzione dell'orario normale corrisponda un aumento
degli straordinari, mantenendo con ciò la stessa quantità di ore lavorate nella
settimana.
14. L'orario annuo consentirà - in molte attività produttive - di ridurre sia lo straordinario nei momenti delle punte produttive sia il rischio della cassa integrazione nei momenti di caduta della domanda. Con una gestione equilibrata degli orari, contemperando con l'orario annuo le oscillazioni connesse agli andamenti degli ordini, ogni nuova quota di mercato può produrre nuova occupazione.
15. L'attuale legge del 24 giugno 1997 prevede
incentivi alla riduzione o rimodulazione degli orari di lavoro determinata dai contratti
collettivi.
L'incentivazione è collegata a dei precisi requisiti: esuberi del personale da
ammortizzare con riduzioni di orario oppure per contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati per l'incremento degli organici.
L'incentivo previsto dalla legge consiste nella RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER
L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA.
Ciò conferisce obbligatoriamente un carattere temporaneo a queste operazioni sugli orari.
Se così non fosse, con l'attuazione del METODO CONTRIBUTIVO nel sistema pensionistico, i
danni futuri sarebbero assai rilevanti.
16. La riduzione degli orari è invece una
politica sociale, al pari di quella salariale, storicamente connessa alla stessa funzione
del sindacato. Una strategia di riduzione generalizzata degli orari è quindi un dato
permanente della politica contrattuale. La sua esecuzione è quindi collegata ad una
analisi non ideologica tra azione sociale e sopportabilità dei costi per il sistema
produttivo.
Con realismo e corretta valutazione economica, la UIL deve programmare una propria
strategia per la riduzione degli orari collegandola al superamento dell'attuale fase di
modesta crescita produttiva e sviluppo contenuto.
UIL HOMEPAGE: http://www.uil.it/

This site is best viewed with Explorer 4.0 v. 800x600